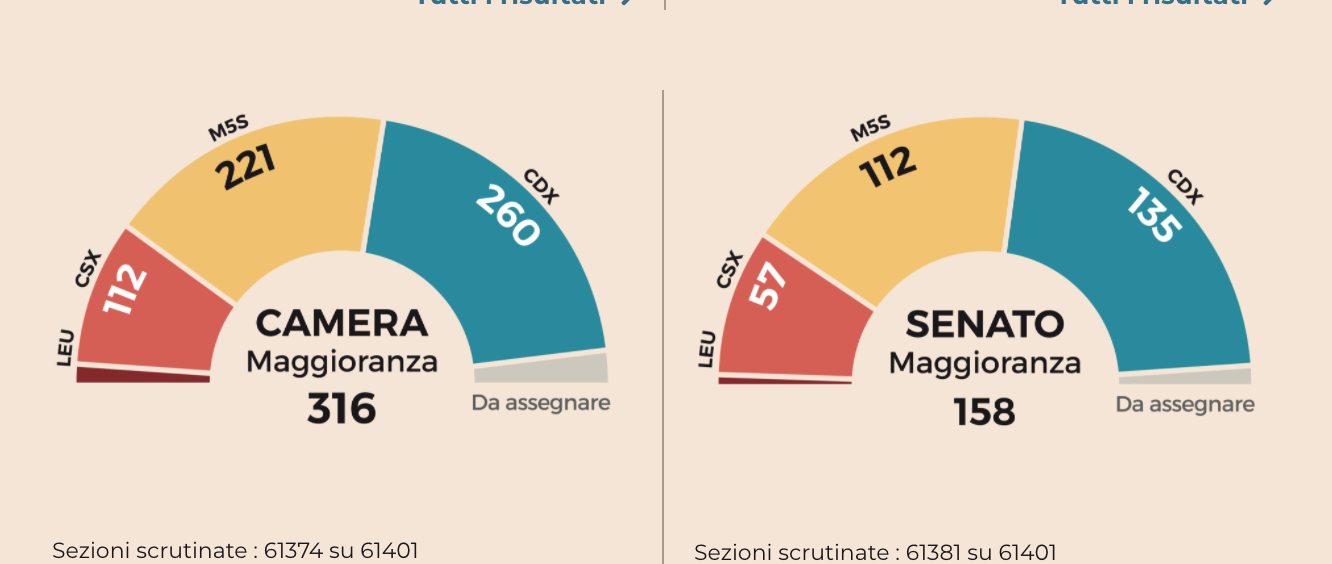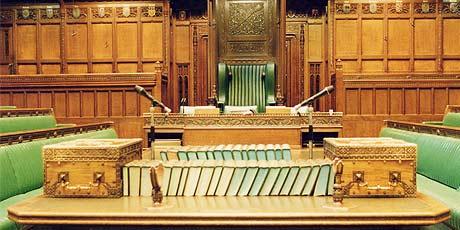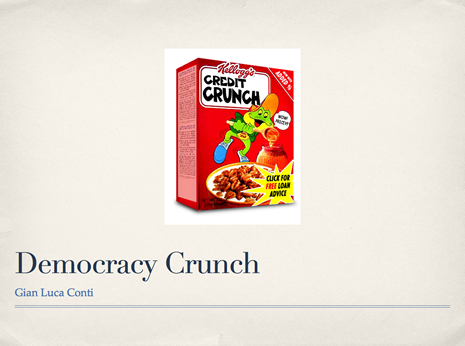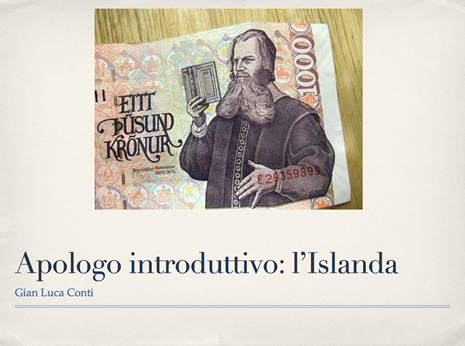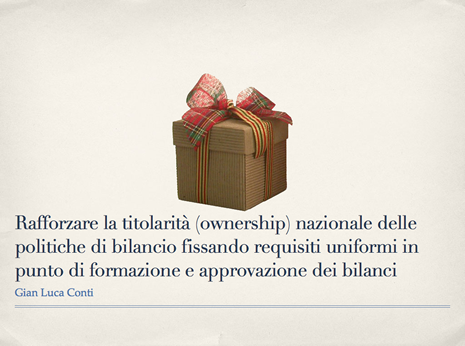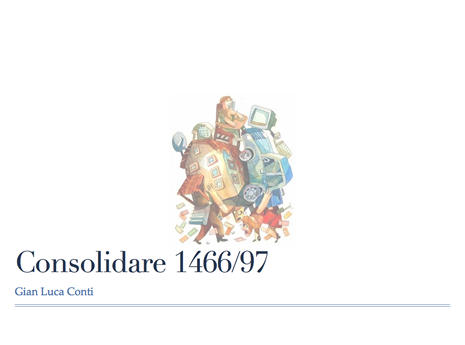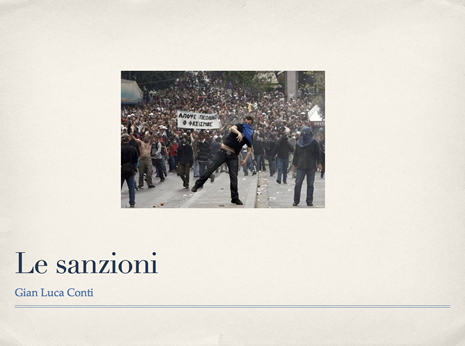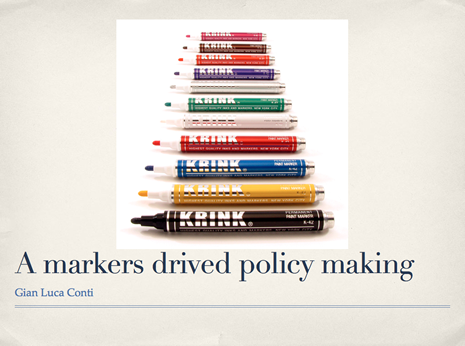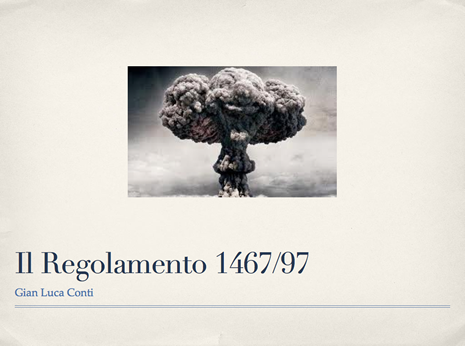20/10/2017

Il quesito referendario del Lombardo Veneto
1 – Domenica 22 ottobre, i cittadini della Lombardia e del Veneto saranno chiamati a rispondere su di un quesito referendario sostanzialmente unitario anche se diversamente formulato nelle due regioni.
In entrambi i casi, viene loro chiesto se vogliono che le regioni Lombardia e Veneto godano di maggiore autonomia secondo quanto previsto dall’art. 116, Cost. e nel rispetto dell’art. 119, Cost.
Questo è il testo del referendum proposto per la Lombardia:
Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?
Molto più stringato il quesito della Regione Veneto:
Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?
La Corte costituzionale, con la sentenza 118/2015, ha precisato che il quesito veneto si riferisce alle materie per cui è consentito alle regioni chiedere maggiore autonomia ai sensi dell’art. 116, Cost.: il quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione cosicché per la Corte deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)».
Il significato del quesito
2 – Per comprendere il significato del quesito si devono comprendere le materie nelle quali è consentito a queste due regioni chiedere maggiore autonomia.
2.1 – Si tratta delle seguenti materie comprese nell’elenco di cui a 117, secondo comma, Cost. (materie in cui lo Stato è titolare di una funzione legislativa esclusiva):
- 117, secondo comma, lett. l): giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace
- 117, secondo comma, lett. n): norme generali sull’istruzione;
- 117, secondo comma, lett. s): tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
La giustizia di pace riguarda poco più che i danni derivanti dalla circolazione stradale, le liti in materia di confini e le questioni condominiali.
Questa competenza non vale a modificare l’ordinamento processuale, ma unicamente l’organizzazione della giustizia (di pace) sul territorio del Lombardo Veneto, sicché le regioni potranno magari decidere di mettere un ufficio del giudice di Pace a Desio o a Bassano del Grappa, ma niente di più.
Le norme generali sull’istruzione sono quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (Corte cost. 200/2009).
In questo ambito, non sembra che vi possa essere spazio per una diversa autonomia del Lombardo Veneto rispetto al restante territorio nazionale: l’esame di maturità, le licenze media ed elementare non possono che restare le stesse su tutto il territorio nazionale ed altrettanto vale per i diplomi di laurea, sia triennale che magistrale.
La lett. s) dell’art. 117, secondo comma, individua la materia (valore: Corte cost. 407/2002) della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
In questo caso, l’autonomia regionale può consistere unicamente della possibilità di stabilire misure più restrittive a tutela dell’ambiente, può prevedere che gli scarichi abbiano un contenuto inferiore di sostanze pericolose, ma non misure meno severe per effetto della giurisprudenza europea in materia di tutela dei beni ambientali.
In altre parole, la maggiore autonomia di cui all’art. 116, Cost. con riferimento alle lett. l), n) ed s) dell’art. 117, secondo comma, Cost. non significa praticamente nulla e, soprattutto, non comporta un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato che sono collegati alle funzioni amministrative esercitate dalle regioni e non ai titoli astratti di competenza legislativa.
2.2 – Non è diverso se si guarda all’art. 117, terzo comma, Cost. che individua le materie in cui spetta alla legge dello Stato definire i principi generali e alle regioni decidere la normativa di dettaglio.
Si tratta:
- rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
- commercio con l’estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
In tutti questi casi, chiedere maggiore autonomia senza stabilire in che cosa consiste la maggiore autonomia che si chiede non significa nulla.
Ad esempio, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia che cosa può chiedere una regione? Una diversa regolamentazione delle interconnessioni attive o una diversa disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici o una disciplina speciale per le concessioni ad uso idroelettrico? Sono tre cose diverse e se non si sa che cosa si chiede è molto difficile sapere se è opportuno chiederlo.
Differenziare il regionalismo
3 – I margini di differenziazione sono molto diversi fra le materie in cui è ammesso il regionalismo differenziato ai sensi di 116 e 117, secondo comma e quelle in cui questa facoltà è ammessa da 116 e 117, terzo comma.
Nel primo caso, non vi sono sostanzialmente margini per una maggiore autonomia, se non su un piano marginale.
Nel secondo caso, vi è la possibilità di concedere maggiore autonomia ma questa possibilità dipende dalle concrete richieste di una regione che intende adattare alla propria identità sociale e consistenza geografica una determinata competenza.
Non stabilire che cosa si chiede rende il referendum vuoto e, perciò, pericoloso.
Fermo il 119
4 – In nessun caso il regionalismo differenziato può modificare le modalità di ripartizione delle risorse fra Stato e autonomie previsto dall’art. 119, Cost.
Il modello dell’art. 119, Cost. non è generoso con le autonomie regionali perché fissa il principio per cui ciascuna regione è titolare delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attribuzioni e non di una parte delle risorse che sono prodotte da quelle regioni.
Questo principio genera inevitabilmente il cd. residuo fiscale, ovvero la differenza fra quanto una regione produce di gettito fiscale e quanto riceve dallo Stato.
Il significato vero del referendum Lombardo si legge nella deliberazione di Consiglio regionale 13 giugno 2017, n. X/1531, che è una mozione che impegna la Giunta regionale e per essa il suo presidente:
- a istituire un Tavolo tecnico allo scopo di individuare il costo unitario e il costo complessivo dei
servizi di fronte al pacchetto di materie negoziabili ex artt. 116 e 117 Cost., nell’ambito della
trattativa con il Governo successiva al referendum;
- a svolgere la trattativa successiva al referendum possibilmente insieme al Governatore del
Veneto, Luca Zaia, impegnato in un analogo percorso referendario, con il deliberato obiettivo di
rafforzare la forza d’impatto nella trattativa interistituzionale con il Governo, che si troverebbe di
fronte i rappresentanti di oltre 15 milioni di abitanti, circa 80 miliardi di euro di residuo fiscale e
circa il 35 per cento del PIL del Paese;
- a convocare un Tavolo, dopo lo svolgimento del referendum, in seno alla Conferenza StatoRegioni
e in accordo con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, composto da tutte
quelle Regioni che vantano un credito annuale nei confronti dello Stato centrale e che guidano la
graduatoria del residuo fiscale, per costituire un “Fronte del Residuo Fiscale” e favorire il
percorso ex art. 116, c. 3, Cost. anche per le altre Regioni virtuose;
- a negoziare, all’indomani dell’esito positivo del referendum, contestualmente alle nuove
competenze e alle risorse relative, anche l’autonomia fiscale così come riconosciuta alle Regioni a
Statuto speciale, nel cui ambito sarebbe inserita la Lombardia all’indomani della conclusione
positiva della trattativa con il Governo, applicando il sacrosanto principio, ormai non più
trascurabile, che le risorse rimangano sui territori che le hanno generate.”
In altre parole, il referendum lombardo serve ad attivare una trattativa con lo Stato centrale in cui la maggiore autonomia di cui all’art. 116 maschera una richiesta di modifica dell’art. 119, Cost.
Un conflitto di attribuzioni mancato
5 – Si è ricordato che per la Corte costituzionale (118/2015), il referendum lombardo – veneto è ammissibile perché si svolte nell’ambito di quanto non vietato dall’art. 116.
Si è visto che il Consiglio regionale della Lombardia ha chiarito con una propria mozione che il significato del referendum è una richiesta di intervento che riguarda 119, Cost.
Il Governo avrebbe dovuto reagire severamente alla mozione approvata dal Consiglio regionale il 13 giugno 2017, proponendo un conflitto di attribuzioni e facendo valere il precedente della Corte costituzionale.
Non lo ha fatto e il suo silenzio merita di essere considerato colpevole.