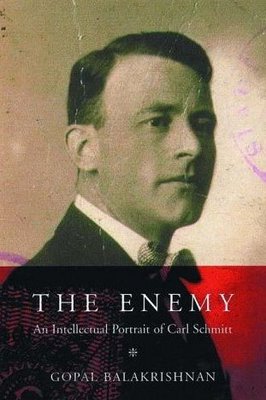Il giudizio sull’incandidabilità sopravvenuta di Belusconi è un giudizio politico? Per un tentativo di risposta a partire dalla celeberrima polemica sul “custode della costituzione”
Condivido gran parte delle affermazioni di Gian Luca Conti e di Carlo Fusaro. La circostanza non mi desta particolare meraviglia perchè la “consuetudine dialettica” di cui entrambi mi onorano da anni ha fatto ormai maturare la consapevolezza di un orizzonte comune. C’è, però, un aspetto della questione di cui in prima battuta non mi sono sentito completamente convinto e, siccome ha poco senso discutere delle cose su cui si è d’accordo, almeno così mi è sempre parso, di questo – e soltanto di questo – vorrei provare a ragionare un po’.
Mi riferisco alla natura del giudizio che il Senato sarà chiamato ad esprimere sull’incandidabilità sopravvenuta dell’On. Berlusconi ed alle pretese regolative che il diritto costituzionale e la sua scienza possono (devono?) avanzare in proposito.
Gian Luca afferma al riguardo che “il giudizio del Parlamento è un giudizio politico, ovvero un giudizio che può prescindere dalla logica della trasformazione di una volontà astratta di legge in volontà concreta di legge per mezzo del sillogisma, un giudizio in cui l’interpretazione della legge si confonde con logiche di parte, un giudizio che altrimenti dovrebbe appartenere alla magistratura”. Carlo Fusaro adesivamente aggiunge che “in quei contesti la scelta è meramente politica, o comunque in ultima analisi politica. […] Quindi tutto il resto son espedienti camuffati da ragionamento giuridico per giustificare o promuovere una certa posizione politica, del tutto legittimamente”.
In estrema sintesi, e con la disinvoltura che Jusbox ci consente, la questione che mi risulta più problematica è compendiabile nella seguente domanda: siamo proprio sicuri che la natura politica del giudizio parlamentare sull’incandidabilità lo ponga al di fuori del dominio del diritto? Detto in maniera più colloquiale: siamo certi che, siccome è un giudizio promanante da un organo politico, allora il ragionamento giuridico non può avere alcuno spazio o dignità?
Io no. Provo a spiegare perché.
L’aspetto fondamentale della questione lo coglie nitidamente Gian Luca quando scrive che, se fosse un giudizio sillogistico, “dovrebbe appartenere alla magistratura”. L’argomento è senza dubbio seducente, ma rischia forse di fare qualche concessione di troppo al decisionismo politico.
Come noto, per Carl Schmitt anche la determinazione del contenuto vincolante di una norma è una decisione, una scelta politica ed importa la risoluzione di un conflitto politico. Per questo motivo, come altrettanto noto, il pensatore renano, nella celeberrima polemica con Kelsen sull’ammissibilità della giustizia costituzionale (più semplicemente, sulla configurabilità di un controllo di costituzionalità delle leggi in forma giurisdizionale), sostiene che tale decisione, quando riguarda l’attribuzione di significato alle norme costiuzionali e il sindacato del loro rispetto da parte della legge parlamentare, non può essere affidata ad un tribunale in veste di custode della costituzione, poiché questo determinerebbe un “sovraccarico” di politicità, incompatibile con il principio di separazione dei poteri, il quale non tollera, “senza mutare la sua posizione all’interno dello Stato di diritto”, che ad un giudice “sia demandata la decisione politica che è di competenza del legislatore” (C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Berlin, 1931, trad. it. A. Caracciolo, Il custode della costituzione, Milano, 1981, 52-63). Dunque, secondo questa prospettiva, almeno così radicalizzata, il Parlamento prende, deve prendere e non può che prendere decisioni politiche, ossia di individuazione dei fini da perseguire e dei mezzi per raggiungerli (quindi, di creazione del diritto). Viceversa, il giudice prende, deve prendere e non può che prendere decisioni giudiziarie, cioè di risoluzione del caso concreto attraverso la norma astratta (quindi, di mera applicazione del diritto).
Ma non si scopre certo nulla di nuovo se si osserva che l’argomento schmittiano prova troppo. Esso tende a dimostare che ogni giudizio che presuppone una interpretazione è un giudizio in una qualche misura politico; il che, però, vale anche per il giudizio reso dal giudice nelle forme e con le garanzie della giurisdizione. È arcinoto, infatti, che tutti i tentativi di arginare l’interpretazione giudiziaria, collocandola nell’alveo della presunta volontà del legislatore hanno, da sempre, dovuto far i conti con le insuperabili obiezioni relative alla natura intrinsecamente ed intimamente creativa dell’attività ermeneutica. Già nel XIX secolo gli esiti nichilisti del “suicidio giurisprudenziale” operato dall’école de l’exégèse (G. Tarello, La scuola dell’esegesi e la sua diffusione in Italia, in Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa, Milano, 1969) sono stati messi in discussione dalla dogmatica della “giurisprudenza dei concetti” (Begriffsjurisprudenz), prima, e dal “movimento del diritto libero” (Freirechtsbewegung), poi. L’attribuzione all’interprete del compito di rinvenire la volontà razionale della legge e non quella empirica del legislatore ridava dignità alla sistematica giuridica, la “scoperta” delle lacune dell’ordinamento giustificava l’opera creativa di integrazione del sistema. Nasceva il mito (destinato a divenire lo spettro) del giurista come personalità (M. Weber, Economia e società, vol. II, Milano, 1974, 192 ss.). Ma in quel contesto l’idea di un giudice che può far fronte alle esigenze assiologiche del caso concreto in quanto dotato di assoluta indipendenza, comprovata moralità e professionalità continuava ad agitarsi nel quadro dei principi teorici dello stato di diritto legislativo imperniato sulla supremazia della legge e la subordinazione ad essa dell’attività giurisdizionale (G. Volpe, Il costituzionalismo del novecento, Roma-Bari, 2000, 22, 31). Nel secolo successivo, invece, il pensiero nazional-socialista, riconoscendo al giudice il ruolo di custode della Volksgemeinschaft, ammetterà che l’interpretazione per attuare i valori della comunità del popolo possa anche andare oltre la legge positiva (C. Schmitt, Stato, movimento, popolo. Le tre membra dell’unità politica (1933), in Id., Principi politici del nazionalsocialismo, Firenze, 1935, 45 ss.). Ed è per questa via che, in meno di cinquant’anni dalla pubblicazione di La legge e l’ufficio del giudice di Oskar von Bulow – al quale gli storici fanno risalire il primo soffio vitale delle dottrine antiformaliste – l’istanza di emancipazione dell’interpretazione giudiziaria ha rischiato di trasformarsi nel canto del cigno dello stato di diritto.
Se si ha presente questa storia non si può non essere portati a rimarcare la consapevolezza che distinguere soggettivamente Parlamento e giudici, ritenendo che il primo prende e debba prendere decisioni solo politiche, mentre i secondi prendono e debbano prendere decisioni solo giudiziarie, trattando le due sfere della politica e della giurisdizione (ossia della creazione e dell’applicazione del diritto) come del tutto separate e reciprocamente impermeabili, è solo apparentemente rispettoso dei principi cardine dello stato di diritto (nella specie della separazione dei poteri). Dietro la difesa della separazione dei poteri, infatti, si nasconde il feroce attacco nei confronti dell’intrinseca falsità dell’astrattezza ed oggettività della legalità parlamentare: la legge generale e astratta, espressione della sovranità popolare, è solo la sublimazione della violenza con cui la maggioranza impone la propria volontà alla minoranza (C. Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von den Souveränität, München-Leipzig, 1922, 24-5; C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle politicizzazioni, in Id., Le categorie del politico: saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio-P. Schiera, Bologna, 1972, 167).
Naturalmente non si evoca questo contesto culturale per sostenere che la qualificazione in termini politici del giudizio che il Senato dovrà dare sull’incandidabilità sopravvenuta dell’On. Berlusconi prelude ad una deriva autoritaria del nostro ordinamento, ma solo per evidenziare che, stante il carattere creativo dell’interpretazione ed il suo pacifico riconoscimento anche nel contesto degli ordinamenti pluralistici sorti dalle ceneri del totalitarismo, le due sfere della politica e della giurisdizione non possono essere così nettamente distinte dal punto di vista soggettivo da poter affermare che il ragionamento giuridico è predicabile della seconda, mentre è del tutto alieno alla prima. E da questo punto di vista la polemica sul “custode della costituzione” continua ad offrire interessanti spunti di riflessione anche se “guardata” per parte kelseniana.
Al teorico del decisionismo che afferma che le questioni di legittimità costituzionale sono questioni eminentemente politiche e che la loro risoluzione non può essere affidata alla giurisdizione, perché a ciò ostano i principi dello stato di diritto, infatti, Kelsen risponde che tale obiezione si basa sul disconoscimento che tra funzioni giurisdizionali (intese come mera attuazione) e funzioni politiche (intese come libera creazione) non esiste una radicale inconciliabilità, poiché ogni attività giurisdizionale reca in grembo caratteri normativi, compresa quella del giudice costituzionale, cui – conseguentemente – non c’è motivo di sottrarre la competenza a conoscere delle questioni di costituzionalità (H. Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, in Die Justiz, 1931, 6, trad. it. C. Geraci, Chi dev’essere il custode della Costituzione?, in Id., La giustizia costituzionale, Milano 1981, 241-4). Il carattere politico è un momento imprescindibile dell’interpretazione giudiziaria, anche di quella del giudice delle leggi, per cui l’asserita natura politica del conflitto sulla costituzionalità non vale in alcun modo a sottrarlo alla sfera del potere giurisdizionale.
Fallacemente indotto a ragionare sul piano della natura della funzione giudiziaria, Kelsen arriva ad ammettere a proposito della ricordata obiezione schmittiana che “tutto ciò che si può dire sul piano di un esame teorico è che la funzione di un tribunale costituzionale ha un carattere politico assai più marcato di quella degli altri tribunali” e che “i fautori della sua istituzione non hanno mai misconosciuto o negato l’eminente significato politico delle sue sentenze; ma non già che si tratti di un tribunale, che la sua funzione non sia giurisdizionale e, tanto meno, che questa funzione non possa essere affidata ad un organo dotato dell’indipendenza giudiziaria”.
Con ogni probabilità il padre della Verfassungsgerichtsbarkeit non si avvede di quanto grande sia la ferita che queste affermazioni aprono nel cuore dei fondamenti teorici della sua proposta politico-costituzionale. Se, infatti, lo scopo della giurisdizione costituzionale è garantire il rispetto della legalità costituzionale attraverso l’annullamento della legge, la cui fattispecie di produzione contrasta con lo schema di produzione giuridica delineato dalla costituzione, il sindacato operato dal giudice speciale non deve in alcun caso estendersi oltre l’astratta verifica della compatibilità logica tra le due norme (legislativa e costituzionale), pena la compromissione della libertà del legislatore di determinare/selezionare il contenuto della norma legislativa tra i possibili che possono essere adottati nel rispetto dello schema e l’introduzione di elementi extragiuridici nel processo di controllo.
Per tale motivo l’affermata natura politica del giudizio svolto dal tribunale costituzionale pone idealmente al vate della dottrina pura del diritto una domanda che rischia di restare senza risposta: se il controllo di conformità a costituzione è esercizio di funzione politico-creativa, assai più di quella giurisdizionale ordinaria, perché esso, in un sistema democratico rappresentativo, deve essere affidato ad un giudice, ancorché speciale? La perniciosa domanda non pare trovare adeguata risposta nella necessità che esso si svolga con le garanzie di indipendenza e imparzialità che solo il procedimento contenzioso è in grado di assicurare (H. Kelsen, ult. cit., p. 259). Anche tale argomento, infatti, come quello schmittiano sul carattere politico dell’interpretazione, prova troppo. Esso dimostra che il contraddittorio è funzionale all’emersione e alla mediazione degli interessi contrastanti che cercano soddisfacimento nella determinazione/selezione – tra i diversi costituzionalmente possibili – del contenuto della legge ad essi strumentale (H. Kelsen, ult. cit., p. 260). Non prova, però, che la natura contenziosa del controllo di costituzionalità debba essere riferita alla procedura seguita da un organo giurisdizionale e non da un organo politico.
Mutatis mutandis si arriva al punto. Una delle lezioni che si ricavano da questa celeberrima pagina della storia del pensiero costituzionalistico continentale è, infatti, che, quanto più si va al cuore dei rapporti tra politica e giurisdizione, ossia quanto più direttamente l’attività di controllo/giudizio investe il Parlamento e i suoi prodotti, tanto più la natura della funzione deve condizionare le forme di esercizio del potere, mentre diventa relativamente indifferente la qualità soggettiva dell’organo titolare della funzione medesima. Detto altrimenti, è la natura della funzione che deve influenzare le modalità di esercizio del potere da parte del soggetto titolare e non, viceversa, la qualità soggettiva del titolare della funzione a condizionare le forme e le garanzie con cui la medesima viene esercitata. Detto ancora diversamente, bisogna ragionare sulla natura della funzione e non sulla natura del soggetto, perché, da un lato, anche organi politici possono esercitare le proprie funzioni in forma giurisdizionale (anzi, la “processualizzazione” delle funzioni politiche è fenomeno storicamente fondato e tendenza attuale del parlamentarismo: L. Buffoni, Processo e pluralismo nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli, 2012, 244 ss.), dall’altro, anche gli organi giurisdizionali compiono valutazioni politiche.
Naturalmente la qualità soggettiva dell’organo è intimamente legata alla natura della funzione, ragion per cui normalmente all’interno degli ordinamenti le funzioni giurisdizionali sono attribuite ad organi giudiziari che, con la loro indipendenza ed autonomia, si trovano, rispetto agli altri poteri, nella condizione ideale per esercitarle. E certamente anche nel caso del giudizio sull’esistenza di una causa di incandidabilità sopravvenuta del parlamentare, come nel caso del controllo sulle cause di ineleggiblità ed incompatibilità, la soluzione costituzionalmente preferibile sarebbe affidare la funzione ad un organo terzo ed imparziale. La funzione in esame, infatti, postula inevitabilmente, per la sua natura logica ancor prima che giuridica, lo sviluppo di un ragionamento sillogistico, dal quale proprio non è possibile – ripeto logicamente, prima che giuridicamente – prescindere, se si vuole verificare se un soggetto concreto versa o meno in una condizione prevista astrattamente dal legislatore come produttiva di una data conseguenza. Ciò non toglie, però, nulla al fatto che, se la funzione è attribuita – per svariate ragioni della cui perdurante fondatezza ormai la dottrina è ampiamente dubbiosa – ad un organo politico, la medesima debba essere comunque esercitata nelle forme della giurisdizione ed atttraverso decisioni giudiziarie, ossia decisioni che applicano la norma astratta al caso concreto attraverso un processo sillogistico. Concludere diversamente vorrebbe dire mettere il carro davanti ai buoi, ossia far discendere la natura del giudizio dalla qualità soggettiva dell’organo.
Per tali ragioni sarei portato a pensare che, secondo il diritto costituzionale e la sua scienza, la circostanza che l’organo titolare della funzione dichiarativa dell’incadidabilità sopravvenuta dell’On. Berlusconi sia la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della sua Camera di appartenza, ossia un organo politico, non debba e non possa condurre alla conclusione che tale funzione verrà esercitata attraverso una decisione politica e non “giudiziaria”. Certo, nell’interpretazione e nell’applicazione della regola astratta il Senato sarà influenzato da considerazioni di carattere politico, ma tali considerazioni, mentre possono entrare nel sillogismo giudiziario, riempiendolo ed orientandolo, non possono snaturare la funzione che il medesimo esercita, la quale non può non essere che una funzione giurisdizionale, ossia una funzione da esercitare nelle forme e con le garanzie della giurisdizione.
O, per lo meno, non la possono snaturare legittimamente, per cui, semmai, il vero problema diventa capire quali strumenti l’ordinamento consente per reagire all’eventuale illegittima condotta della competente Giunta del Senato che ometta l’applicazione sillogistica delle cause di incandidabilità non dichiarandone la soppravvenienza nel caso concreto. Al riguardo si può forse immaginare di riconsocere la legittimazione attiva alla proposizione di un conflitto di attribuzioni tra poteri in capo all’autorità giudiziaria penale che ha adottato la sentenza passata in giudicato che integra in concreto la fattispecie di incandidabilità astrattamente prevista dal legislatore. La decisione della Giunta che nega la dichiarazione di incandidabilità sopravvenuta frodando il sillogismo giudiziario, rendendolo manifestamente illogico anche ad un controllo “solo” esterno e facendolo sopravanzare da valutazioni politiche eccedenti il carattere intrinsecamente creativo dell’interpretazione giuridica, infatti, costituirebbe una interferenza rispetto all’ordinario esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice che ha emesso il giudicato di condanna, i cui effetti in punto di incandidabilità, nel caso del parlamentare in carica che non si ricandidi, verrebbero sostanzialmente posti nel nulla dalla decisione politica della Giunta.